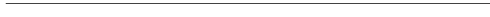Animali d’affezione, cioè tutti
Durante i mei 4 anni di vita a Sao Tomé e Principe non avevo cani o gatti con me. Gli animali di compagnia non erano visti di buon occhio; per gli africani negli anni ’80 il mondo animale si divideva in due grandi classi, alla faccia di Linneo: gli elementi pericolosi – categoria in cui i cani, le scolopendre e il mamba nero venivano raggruppati – e la classe cibo, che accoglieva tutte le altre specie.
“C’est la bouffe qui passe patronne!” rispose un giorno uno dei portatori gabonesi alla mia richiesta di conoscere il nome di un serpente che ci aveva attraversato la strada.
Italiani brava gente: “io non ti mangio”
I santomensi mangiavano qualunque tipo di selvaggina o pesce, escluse le aragoste; quelle per loro erano spazzatura nemica, che distruggeva le reti con le chele. Una volta compreso che noi ne andavamo ghiotti, cominciarono a vendercele, a prezzi sempre più cari, via via che la richiesta aumentava, secondo le migliori regole dell’ortodossia economica. Poi provarono a proporci altri animali, che noi rifiutammo categoricamente di mangiare. Dopo l’episodio di un gabbiano ferito, portato a casa di una mia collega in veste di merce edibile e amorevolmente risparmiato e curato, la voce che i cooperanti italiani erano un po’ malucos (pazzi eccentrici) e invece di mangiare gli animali se li tenevano in casa, si sparse. Da quel giorno ci fu offerto (a pagamento) di tutto e in continuazione: gatti con le gambe spezzate, cani rognosi tramortiti da scontri con jeep e camionette, galline sperdute.
Gallina salva fa buona compagnia
La mia amica Alessandra costruì addirittura una scaletta perché la sua gallina, salvata dalla morte, potesse uscire da sola a passeggio nella corte, passando dalla finestra.
Gallina era molto abile a evitare gli agguati dei bambini che cercavano di trasformarla in pasto, si vedeva che era una consumata ribelle, sfuggita a precedenti insidie per perizia o perché covata sotto una buona stella.
Gino capretto clandestino
A Pasqua il falegname del villaggio ci chiamò per donarci un capretto, in segno di riconoscenza per la nostra collega medico, che aveva curato suo figlio. Eravamo veramente afflitte: dovemmo andare da lui a caricare sulla jeep il capretto legato e urlante. Facemmo finta di accettare. Fu un viaggio infernale, fortunatamente breve. Una volta a casa Gino (il capretto lo chiamammo così) fu liberato dalle corde e rimase a vivere con noi. Al nostro autista fu fatto giurare di mantenere il segreto sulla sua sopravvivenza e l’empregada (la governante) fu istruita a montare la guardia per nascondere Gino in caso fosse apparso il falegname all’orizzonte.
Evento che fortunatamente non si verificò, perché di sicuro Gino avrebbe scelto il momento più inopportuno per belare a pieni polmoni. In segno di gratitudine Gino il clandestino divorava qualunque pianta, ortaggio, oggetto, ferramenta di piccola taglia, trovasse in cortile. Teneva tutto molto pulito, purtroppo il suo concetto di pulizia includeva anche scarpe e indumenti, di cui Gino si serviva tirandoli giù direttamente dalle corde su cui venivano sciorinati.
Umidi gli piacevano molto.
La Gaia belva
Fu così, grazie al nostro sconsiderato amore per gli animali, che arrivò da noi anche Gaia.
Con notevole sforzo creativo Stefano e Lidia l’avevano chiamata Gaia perché il nome che le davano i santomensi era Lagaia. Si trattava di uno zibetto africano. Non sapevamo nemmeno se fosse maschio o femmina, ma ormai per noi era Gaia.
Carinissima, con un musetto simpatico e una folta pelliccia, rischiava e rischia tuttora la vita perché è considerata un pasto prelibato e la sua pelliccia è molto apprezzata come ornamento. Era così tenera che ce ne innamorammo subito, senza minimamente curarci di prendere informazioni su di lei. All’epoca il concetto di specie protetta era di là da venire e noi eravamo sinceri e inconsapevoli amanti degli animali: al massimo si pensava a proteggere le balene o il panda gigante.
Ben presto Gaia si rivelò l’ottava piaga d’Egitto.
Mordeva come una tigre, puzzava come un orinatoio, ringhiava con voce da iena, quando era incazzata (accadeva spesso che lo fosse) si gonfiava come un gatto furioso e nottetempo razziava con metodo i pollai dei vicini, che il giorno dopo si presentavano alla nostra porta con i resti dei cadaveri sanguinanti, esigendo giustizia e rimborso.
Mettendomi nei suoi panni, anzi nella sua pelliccia, comprendo adesso quanto dovesse soffrire un animale notturno, selvatico, solitario, cacciatore e carnivoro, abituato a dormire di giorno nella vegetazione fitta e a nutrirsi uccidendo anche grandi prede, nel ritrovarsi chiuso in una casa con un gruppo di umani bene intenzionati, ma sprovveduti e ignoranti, che cercavano di grattarle la pancia, accarezzarla e farla diventare vegetariana.
Io avrei ucciso per molto meno.
I meno decerebrati del gruppo si opposero a questa tortura e riuscimmo a convincere gli altri a liberare Gaia nel suo habitat.
La liberazione di Gaia
Organizzammo una spedizione con l’aiuto di Fernando, il nostro autista, che si prestò, a malincuore, ad aiutarci a rilasciare nella foresta quell’ottimo bocconcino. Facemmo costruire una solida gabbia in legno e Gaia fu incappucciata e legata per l’ultima volta. Si difese con ardimento e, malgrado gli spessi guanti da lavoro che gli indomiti mercenari, da noi ingaggiati per la bisogna, indossavano per proteggersi, Gaia lasciò il segno.
Durante il trasportò ringhiò, graffiò, cagò, pisciò e produsse secrezioni ripugnanti che ci accompagnarono per mesi, come monito a lasciare in pace la fauna selvatica. Di sicuro l’eroico zibetto insegnò la lezione anche ai locali, che da quel momento si guardarono bene dal portarcene altri esemplari.
Billy, lo Jacquot innamorato
Uno dei rari santomensi che possedevano animali di compagnia era il fratello del ministro dell’Economia, che lavorava alla sede locale delle Nazioni Unite. Era anche il mio compagno, diciamo la relazione principale che intrattenevo in quei tempi di giovanili follie, in cui mi ero adeguata senza problemi all’allegra gestione dei rapporti intimi con l’altro sesso.

Lui viveva con Billy, un pappagallo parlante, per l’esattezza era un pappagallo cenerino, uno Jacquot, quelli bruttarelli, grigi con la coda rossa, gli unici in grado di produrre suoni simili alla voce umana, un po’ come i merli indiani. Pare siano super intelligenti e morbosamente affezionati ai loro padroni. In effetti Billy adorava il suo padrone e quando lui ed io litigavamo mi inseguiva per becchettarmi le caviglie.
A me non piaceva, non ho mai avuto grande simpatia per i pennuti e capivo benissimo che per Billy ero la rivale, l’intrusa che gli contendeva le attenzioni del suo grande amore. Io abitavo in un’altra casa, ma quando andavo a casa del mio compagno in sua assenza, non appena l’empregada socchiudeva la porta, alle sue spalle si palesava Billy, giunto a controllare chi fosse che aveva bussato. Se i suo unico amore era presente Billy gli saltellava intorno ripetendo insistentemente: “cossa Billy, cossa”, “gratta Billy, grattalo”, dandogli colpettini con la testa contro le mani per farsi grattare le piume.
Benché mi infastidisse riconosco che era uno spettacolo di seduzione unico: Billy inclinava il capino, si sprimacciava le piume, faceva la ruota con le ali e poi sbirciava il suo amore coprendosi vezzosamente il becco con l’ala a guisa di ventaglio, avvicinandosi di sghimbescio, accennando passi di danza. Queste premure erano esclusivamente riservate all’oggetto della sua devozione e non mi restava che attendere pazientemente che l’amoreggiamento terminasse, sennò le mie caviglie ne avrebbero fatto le spese.
Tutti questi animali popolavano le case dei miei amici e colleghi.
Infine una sera giunse anche per me l’incontro con il mio animale d’affezione santomense.
Corniglio e la sua progenie
Stavo tornando dal Bataclàn, l’unica discoteca dell’isola, insieme alla mia amica, quando vedemmo, fermo in mezzo alla strada, abbagliato dai fari dell’auto, un coniglio bianco.
Inchiodai la jeep e scesi per raccogliere l’incauto coniglio autostoppista prima che qualche santomense lo scorgesse e se lo portasse a casa per farlo finire in pentola. Lì per lì non avevo un piano; l’obiettivo immediato era salvargli la vita. Arrivate a casa la mia amica ed io chiudemmo Coniglio in ufficio, dove lui passò la notte rosicchiando tutti i cavi elettrici che riuscì a raggiungere. Il giorno successivo chiamammo un veterinario e l’elettricista.
Del veterinario in seguito non ci fu più bisogno, mentre con l’elettricista avremmo stretto un patto a vita.
Gli venne dato il nome Coniglio, che i santomensi trasformarono in Cornelio, perché in porrtoghese coniglio si dice “coelho” e avevano pensato che invece Coniglio significasse Cornelio in italiano. A quel punto decisi di attuare un’operazione di sincretismo culturale chiamandolo Corniglio e quel nome gli rimase finché ebbe vita. Una vita che fu lunga, serena e prolifica.
Tra la corale disapprovazione del personale santomense Corniglio fu accolto in casa non come portata in un menù, ma come membro della cooperazione italiana a Sao Tomé e Principe.
Pensammo di lasciarlo libero in giardino e la scelta fu di suo gradimento. Corniglio cominciò a scavare peggio di una talpa, destando le ire del giardiniere che si vedeva devastare il frutto delle quotidiane fatiche. La bastardaggine di Corniglio era pari alla lunghezza delle sue orecchie e lo spingeva a scavare proprio nelle aiuole e nel terriccio dissodato di fresco, che gli richiedeva un minor impegno nell’operazione. Alle sue perforazioni non sopravviveva nulla e alla fine l’ebbe vinta lui: il giardiniere si arrese a non avere in giardino che alberi di grosso fusto ed erba infestante, rinunciò ai fiori e Corniglio restò dominatore assoluto del territorio. Preoccupate per l’equilibrio psicofisico di Corniglio pensammo che, se gli avessimo trovato una compagna, anziché bucherellare il terreno, magari si sarebbe impegnato in altre attività ludiche. Immemori del significato del detto “figliare come conigli” contattammo un allevamento e comprammo Corniglia.
Lei si comportò secondo natura: 5 parti all’anno, con 10 – 12 corniglietti ad ogni parto. I corniglietti appena nati stavano con lei, poi, per proteggerli da cani e gatti, li trasferivamo in ufficio, dove loro rosicchiavano con perizia tutti i cavi elettrici. Arrivava l’immancabile elettricista che ogni volta si stupiva del fatto che i roditori non restassero mai fulminati, riparava i cavi e ci proponeva di acquistare in blocco i guastatori. Al nostro fermo rifiuto se ne andava ridendo e scuotendo la testa. Quando i corniglietti erano cresciutelli andavano ad accrescere le schiere dei conigli ormai inselvatichiti che popolavano lo spazio all’aperto e la storia proseguiva: il nostro giardino era diventato la collina dei conigli.
Pareva che la colonia dei Cornigli sapesse di abitare in una zona franca, perché se ne stavano lì a scavare, senza alcuna pulsione a esplorare l’infido spazio oltre la recinzione. I predatori, umani e animali, erano però in agguato, quindi ci sentimmo in dovere di assumere un guardiano diurno e uno notturno (armati di machete) per proteggere i Cornigli. La nostra fama di malucos (pazzi eccentrici) si sparse in tutta l’isola e i bambini accorrevano a vedere quei matti degli italiani che pagavano elettricisti e guardiani per tenersi degli inutili conigli vivi in giardino, mentre avrebbero potuto mangiarseli.
Ogni mattina Fausta, la nostra empregada, anziché dirci “bom dia”, scuoteva la testa, guardava noi, poi i Cornigli, poi di nuovo noi, riscuoteva la testa e pronunciava lapidaria la sua sentenza “que gasto!” che spreco!